postato il 20 Ottobre 2011
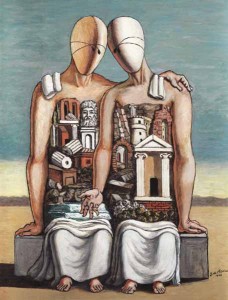 “Riceviamo e pubblichiamo” di Davide Delfino
“Riceviamo e pubblichiamo” di Davide Delfino
Fin dai suoi esordi l’archeologia ha potuto contare su forti appoggi da parte della politica e delle ideologie. Si possono citare brevemente: l’incoraggiamento, in funzione nazionalista, di Napoleone III per le antichitá celtiche; l’incentivare, tra il XIX e il XX secolo, scavi nel Vicino Oriente e nell’Egeo da parte di Inghilterra, Francia, Germania e Italia, volto a rafforzare la presenza politica e l’egemonia culturale di questi Paesi; l’interesse dei nazisti per le ricerche della Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe finalizzate a trovare le tracce dell’ancestrale popolo ariano; l’appoggio del governo di Mussolini alle ricerche sulle antichitá romane; il proliferare nell’ Unione Sovietica del dopoguerra delle ricerche sui sistemi di produzione antichi, nell’ottica di dar risalto al lavoro operaio nel corso della storia.
Spesso la ricerca archeologica ebbe, quindi, supporto da parte dei poteri forti perché serviva, direttamente o indirettamente, per degli scopi politici, ideologici, geostrategici. Ora, nel tempo da molti considerato come periodo post ideologico, quale puó essere l’interesse della politca per l’archeologia e lo studio della storia dell’uomo in generale? Bisogna, prima, premettere due punti: 1) in passato le Scienze Archeologiche servirono per finalitá anche di basso profilo etico, basta scorrere alcuni degli esempi citati poc’anzi; 2) si intenderá in questa sede la parola politica non come lotta o dibattito tra partiti, ma nel suo significato piú ampio e genuino, ovvero: politica come comunitá di cittadini responsabili che direttamente o indirettamente prendono parte alla gestione della Stato, o meglio, nel senso aristotelico, “politica come amministrazione dello Stato per il bene di tutti”. (Aristotele: Politica)
Da un recente dibattito su “Politica e Archeologia” occorso durante il recente XVI Congresso dell’ Unione Intrenazionale di Scienze Presistoriche e Protostoriche (U.I.S.P.P.) tenutosi a Florianopolis in Brasile e co-coordinato dallo scrivente assieme a colleghi sud americani, é emerso che la politica, sia intesa come comunitá di cittadini che come Governi, ha bisogno dell’archeologia, soprattutto come motore di aggregazione sociale e di rilancio economico. Un esempio per chiarire. In Portogallo nel 1994 ci fu una forte battaglia civica in difesa delle migliaia di incisioni rupestri nella Valle del fiume Côa: in quell’occasione, quello che poi sarebbe diventato un patrimonio protetto dall’ U.N.E.S.C.O. rischiava di finire sotto le acque di un bacino idrico artificiale in progetto; si mossero comitati civici e singoli cittadini per salvare le incisioni, che risalgono in gran parte a 30.000/15.000 anni fa, e in questo frangente gli archeologi furono un agente determinante e il patrimonio archeologico un potente fattore di aggregazione sociale.
Per le “politiche” di oggi qual’ é l’utilitá dell’ archeologia e degli archeologi? A livello globale, piú strategico, un archeologo ha una visione panoramica su molteplici problemi che i governanti d’oggi si trovano ad affrontare, in quanto egli si dedica ad una disciplina che é multidisciplinare: non fraintendiamo, l’archeologo non é specialista in tutto. Ma lavora a fianco di geologi, antropologi, chimici, fisici, biologi, e anche storici, teorici dell’economia, artisti e talvolta filosofi. Avendo un contatto professionale con questi esponenti di vari discipline, riesce ad avere una panoramica di differenti visioni, approcci e saperi. Per esempio i problemi della gestione delle risorse naturali, oggi cosí attuali nella progressiva desertificazione di molte aree o nella carenza di forme di energia rinnovabili, sono, un motivo molto forte nello studio dei periodi antichi. E non solo usando i metodi che tutti conoscono e legano alla figura di “Indiana Jones”: si lavora bensí anche con la paleobotanica, lo studio dei suoli, l’antropologia, la geografia fisica, l’archeologia della produzione (che implica lo studio dell’uso e della gestione dei materiali). Un altro esempio illuminante é lo studio del paleoclima: non é una novitá per gli archeologi che l’uomo, nel corso della sua storia fin dall’ultima glaciazione (110.000-12.000 anni fa), ha sempre dovuto adattarsi all’ambiente circostante per sopravvivere: innovare le tecnologie che non erano redditize, mantenere quelle che garantivano il massimo risultato con il minimo costo, cambiare stile di vita e, spesso, territorio a seconda delle possibilitá di sopravvivenza.
Queste esperienze di lavoro multidisciplinari e applicate a periodi storici e preistorici, danno all’archeologo la capacitá di avere una visione pluridirezionale, stereoscopica delle cose e, nel contempo, di trasmettere alla comunitá, alla politica odierna, insegnamenti per gestire la”cosa pubblica” traendo spunto dalle scelte, ma anche dagli errori, dei nostri antenati.
In periodi di “crisi” come quello che viviamo ora, é quanto mai importante la gestione territoriale: 1)avere la capacitá di interpretare le necessitá e le potenzialitá nascoste di un territorio conoscendo la sua storia, le attivitá che l’ hanno costruita, le comunitá umane che l’hanno popolato fin dai tempi piú antichi 2) riuscire in base a questa analisi a trovare la soluzione migliore per coordinare delle azioni che possano rilanciare l’economia locale, soprattutto portando persone su quel territorio. Probabilmente in tutto ció la figura di un archeologo puó avere una parte importante e, forse, anche indispensabile
Che cosa puó dare la politica all’ archeologia? Sarebbe troppo banale dire finanziamenti. Forse é piú originale, concreto e fattibile dire: 1)appoggio a livello istituzionale; 2) piú spazio nei luoghi di gestione territoriale; 3)aiutare la visibilitá mediatica non dei novelli “Indiana Jones” degli archeoclub, ma dei professionisti che tutti i giorni lavorano sui cantieri, fanno formazione nelle Universitá (non solo i professori, ma i ricercatori che tengono i corsi senza ricevere un euro), realizzano incontri nazionali ed internazionali dove si dibatte sui grandi temi del passato che interessano anche il presente e il futuro, cercano di valorizzare il patrimonio archeologico e la ricerca sul campo sul territorio ( e con questo indirettamente contribuiscono al rilancio delle piccole economie locali); 4) facilitare un’azione educativa verso le nuove generazioni affinché comprendano che la conoscenza e la curiositá per il passato puó aiutare a gestire meglio il presente e pianificare in modo piú consapevole i futuro.
Infine, per tornare alla storia della disciplina, molti tra i piú noti archeologi ed epigrafisti italiani del “periodo d’oro” delle ricerche ( tra la fine del XIX secolo e gli anni ’20 del XX) sono stati senatori, legati quindi direttamente alla gestione dello Stato: Luigi Pigorini (1842-1925), Paolo Orsi (1859-1935), Domenico Comparetti ( 1835-1927), Giacomo Boni (1859-1925), Angelo Mosso (1846-1910). Ció non significa che l’archeologia italiana debba avere dei propri rappresentanti in Parlamento; ma se chi vi si trova avesse maggiore attenzione per la carenza di visibilitá istituzionale e la potenzialitá che ha l’archeologia e hanno gli archeologi per il futuro del Paese, sicuramente si avrebbe lo stesso un fondamentale contributo.






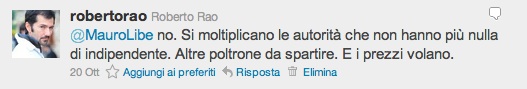




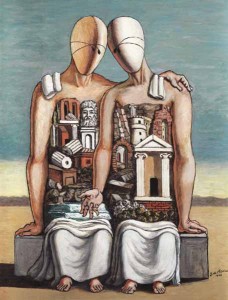


 Facebook
Facebook Youtube
Youtube Flickr
Flickr Blip.tv
Blip.tv Delicious
Delicious Twitter
Twitter Dopplr
Dopplr